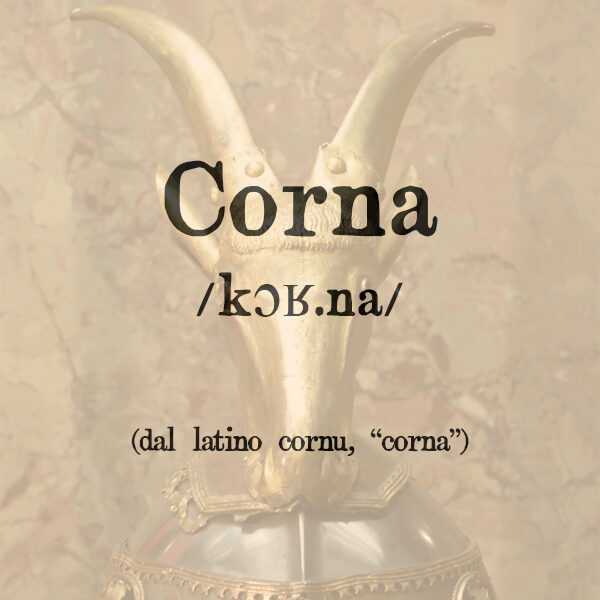Corna, pl. f.
Con il viaggio etimologico di questa settimana vi portiamo alla scoperta di un pezzo della nostra storia patria, raccontandovi uno di quegli aneddoti da tenere come asso nella manica da estrarre come uscita di emergenza per far desistere le persone dal continuare a frequentarvi.
Il lemma di oggi è Corna. Che c’entra con la storia del diritto? Molto di più di quanto si possa pensare.
Certo è che attribuire l’epiteto di “cornuto” a qualcuno, facendo nome e cognome, promuove questa ingiuria al rango di vera diffamazione e propria, proiettando il mittente nel mondo degli illeciti penali.
C’è stato un tempo in cui però questo tipo di ingiuria non si limitava all’ambito verbale, ma veniva accompagnata da gesti pittoreschi e molto teatrali, per rendere partecipi tutti i concittadini dello status della vittima prescelta.
Ma andiamo con ordine: l’etimologia.
Corna, al pari di corno, deriva dal latino CORNU, “corna”, con radice nel Proto Indo Europeo *ḱerh₂-, sempre indicante la prominenza ossea degli animali. L’inglese “horn” è direttamente collegato alla stessa radice.
Scavando più a fondo, forse il termine Proto Indo Europeo trova la propria genesi nel verbo *ḱer-, “crescere, nutrire”, perfettamente aderente alla proprietà delle corna, che non si accorciano mai, e possono solo crescere. Sì dai, questa era cattiva, lo so.
Vi siete mai chiesti da dove derivi la connessione tra appendice ossea animale e adulterio?
Anticamente, in epoca Classica come nell’Alto Medioevo, le corna avevano un’accezione positiva, simbolo di virilità e forza divina, quando attribuite ad un condottiero o ad un guerriero.
Pensiamo all’epiteto Dhu al-Qarnayn, “il Bicorne”, forse attributo nel Corano ad Alessandro Magno, le cui rappresentazioni numismatiche come marmoree spesso lo vedono ritratto, elegantemente, corna-munito. Come se non bastasse, Alessandro aveva un elmo dotato di corna, donatogli al tempo della conquista dell’Egitto. Anche Pirro, Re dell’Epiro, si presentava in battaglia con un elmo adorno di enormi corna, simbolo di potere divino. Lo stesso si può dire dei guerrieri Galli e Germani.
L’unione dell’imago dell’Alessandro Magno bicorne e dell’elmo di Pirro, confluirono nel XV secolo nel disegno dello splendido Elmo di Scanderbeg, appartenuto a Giorgio Castriota Scanderbeg, principe di Albania dal 1444 al 1468.
Ma come si arrivò al drastico cambiamento di significato, di cui noi godiamo oggi l’eredità intellettuale?
Accadde che nel XII secolo Andronico I Comneno divenne imperatore Bizantino. Abile e scaltro condottiero, ma altrettanto crudele, la storia ce lo tramanda come ferocissimo tombeur de femmes: nessuna donna poteva sottrarsi dal suo desiderio, nemmeno quelle sposate. Per lui la conquista della preda era, evidentemente, come la vittoria di una battaglia; per quelle più ambite, come le donne di alto lignaggio, non mancava di fare imprigionare i mariti per evitare distrazioni, per poi marcare la propria visita di cortesia appendendo alle porte dell’abitazione dei coniugi teste mozzate di animali dotati di enormi corna. Un trofeo di caccia.
Nel 1885 l’esercito di Guglielmo II di Sicilia, allora in guerra con Andronico I, stava avanzando verso Bisanzio. I soldati siciliani non poterono fare a meno di notare questi trofei sparsi per le lande, e chiarita la storia che nascondevano, pare furono proprio loro ad importare in patria non solo l’appellativo di “cornuto”, dedicato al marito sfortunato, ma anche l’uso di appendere corna in segno di sfregio ed ingiuria generale, al di là dell’adulterio.
La pratica si diffuse ben presto in quello che sarebbe divenuto il Regno di Sicilia prima, poi in tutta la penisola, e ovviamente iniziò a creare non pochi problemi tra regolamenti di conti e duelli d’onore.
In una Grida contra gli atti tirannici del 15 agosto 1627 di Gonzalo Fernández de Córdoba, reso celebre dal Manzoni come uno dei personaggi più detestabili de I Promessi Sposi, leggiamo, tra le tante cose vietate:
18. abbandonarsi a sassaiole, imbrattamenti di porte e di case, affissioni di corna, cerchi e libelli famosi, e ad altri atti illeciti e vituperosi per macchiare o tentar di macchiare l’honore et reputatione altrui.
Nel XVIII secolo è invece il giurista e cardinale Giovan Battista De Luca, nel suo Dottor Volgare, a farci una descrizione molto dettagliata delle cornacome delitto:
Quella specie di delitto non ha provisione speciale nella legge commune , ma cade fotto il genere dell’ingiurie, o veramente de’ Libelli Famosì, o pure fono il genere dello Stellionato: Ma perché (secondo li diverse usanze de’ paesi) ciò si suole apprendere, più o meno, sicché in alcune Parti importa un’ingiuria molto grave, la quale necessita alla vendetta, ed a risentimenti , li quali cagionano de’ scandali, e degli inconvenienti gravi; però da per tutto sta provisto con leggi , o bandi particolari, sicché non è materia capace d’una regola certa e generale applicabile a tutti i casi, ed a tutti i paesi.
Egli continua approfondendo la particolarità legislativa del Regno di Napoli, dove del resto esercitava:
Nel Regno di Napoli questa sorte d’ingiurie, che si faccia col buttare delle Corna avanti la porta, o la casa di qualch’uno, o d’attaccarle al muro, o alle porte, e di sporcare le medesime parti con sterco, o con inchiostro, o col fare cose simili, si esplica col termine, o vocabolo generale della macriata.
La “macra” era una tintura di colore rosso intenso che, tra gli altri usi, veniva utilizzata per marchiare le case degli uomini le cui consorti erano risultate infedeli. Le fonti però ci dicono che i prodi denunziatori notturni potevano dare ampio spazio alla propria fantasia, utilizzando preferibilmente corna – per l’appunto – e lanciando pietre alle finestre per rincarare la dose.
Un bando del 1549 voluto da Don Pedro de Toledo l’aveva condannata a reato, ma l’uso perdurò, evidentemente, nel tempo.
Il De Luca prosegue con la descrizione delle pene previste per i trasgressori, e facendo una interessante distinzione tra vittime oneste e vittime disoneste:
(…) e porta delle pene gravi, imposte per quelle leggi : ed in questo Principato, per i bandimenti generali, vi è la pena della galera, ed anche della vita, ad arbitrio da regolarsi secondo le circostanze de’ casì, e secondo la qualità delle persone, alle quali si faccia tal ingiuria : Attesocché, sebbene i bandimenti così dispongono indifferentemente , anche quando ciò seguisse nelle case di meretrici , e dell’altre persone disoneste, o vili, onde il caso non sia per cagionare molti inconvenienti, come sarebbe quando si faccia alle persone oneste, o qualificate; Nondimeno ciò si deve, diversamente praticare più i un caso, che nell’altro.
Oggi questi aneddoti ci riportano ad usanze ormai debellate che ci sembrano quasi goliardiche, perpetuate oggi solo in casi isolati e meno creativi, come scritte (spesso sgrammaticate) sotto la casa o sulla carrozzeria dell’auto del malcapitato.
Non possiamo che chiudere con una citazione di Totò che, tra i suoi capolavori, spesso riprendeva un certo gusto borbonico nella rassegnata eredità del “cornuto”. Come nella poesia Filosofia del Cornuto, dove leggiamo in chiosa:
‘ncoppa a sti ccorne fatte nu surriso,
ca pure Napulione era cornuto!.
Bibliografia e link di riferimento
Corna, in GDLI, Grande Dizionario della Lingua Italiana, UTET.
Cornus, Cornu, in Charlton T. Lewis and Charles Short, A Latin Dictionary, Oxford, Clarendon Press, 1879.
²ḱer-, in Pokorny, Julius, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [Indo-European Etymological Dictionary], Vol. II, Bern, München: Francke Verlag, 1959.
Nicolini, Fausto, Scritti di archivistica e di ricerca storica (raccolta a c. di Benedetto Nicolini), Ministero dell’Interno, Pubblicazioni a cura dell’Archivio di Stato, LXXXV, Roma, 1971.
Giovan Battista de Luca, Il dottor volgare, ovvero Il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale, nelle cose piu ricevute in pratica, moralizzato in lingua italiana da Gio. Battista De Luca, Tomo V, Modesto Fenzo, Colonia, 1740.
Andronico I Comneno, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica.
Lucia Nadin, Testimonianze manoscritte sull’Armatura e le armi di Scandenberg, Palaver Palaver 8 (2019), n. 2, 109-124.
Image Credits: Decorative helmet of Gjergj Kastrioti Skanderbeg, c. 1460.
Milano, 1988. UX Designer e Project manager, dottoressa in Filologia Moderna. Appassionata di vino, cose vecchie e storia della lingua.