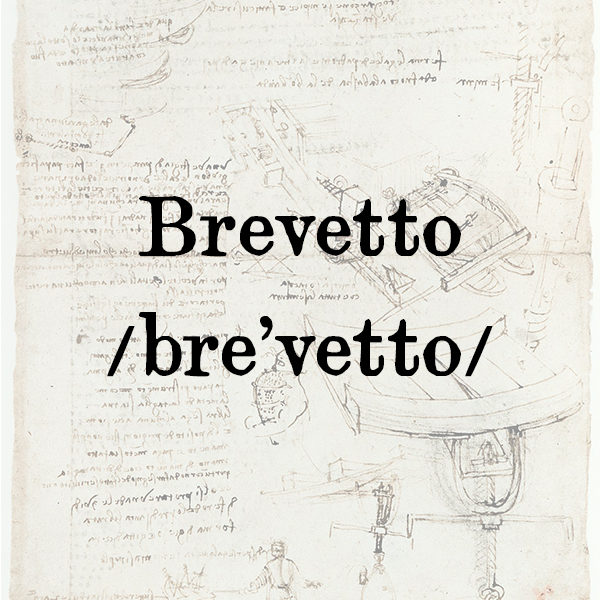Brevetto, s.m.
Il percorso linguistico di questo termine offre un esempio interessante di “refurtiva tornata in patria” e vedremo insieme perché.
L’origine si trova nel latino BREVIS, BREVE, “corto, specialmente di tempo”. La radice di questo lemma ci permette di fare un tour europeo lampo: la forma latina infatti sembra trovare origine in un non attestata *bregvis, che condivide qualcosa in comune con il greco βραχύς “breve”, il germanico BRECH, “spezzare, rompere” e (rullo di tamburi) l’antico irlandese BREIB e BRÌ “breve, corto”.
Il viaggio continua nel latino medievale, quando il termine venne attribuito ai brevia, documenti redatti dai notai al fine di tenere traccia di negozi, mentre nell’età comunale i brevia erano invece integrazioni agli statuti, elencanti mansioni e quant’altro riguardasse aspetti normativi delle magistrature; tanta era la loro rilevanza da diventare poi lo stesso termine con cui venivano indicati gli statuti stessi, di comuni, associazioni, confraternite.
Spostiamoci in Francia dove i bref avevamo la stessa funzione giuridica, ed erano emanazioni ufficiali a cura di un notaio. Il termine in ambito giuridico mantenne la stessa accezione anche nel diminutivo brevet che designava documenti per ufficializzare benefici di vario uso e consumo.
Ma dove sta la protezione della proprietà intellettuale in tutto questo?
Torniamo in Italia. È il 1421 e in una Firenze euforica per la costruzione del nuovo Duomo, la città concede a Filippo Brunelleschi un brevetto di 3 anni per la costruzione di un badalone, una barca per il trasporto del marmo destinato alla costruzione dell’imponente struttura religiosa lungo l’Arno. Come altre esperienze registrate nello stesso periodo in Inghilterra con le patents di Enrico IV, erano forme giuridiche tese ad attrarre tecnologie più che a proteggerle.
Il primo passo in questo senso lo abbiamo nel 1474 a Venezia, con l’emanazione da parte del Senato di una legge che sanciva la protezione di inventore e invenzione per la durata di 10 anni, sul territorio della Serenissima, tramite privilegi.
Gli anni a seguire videro il fiorire di privilegi in Italia e Francia e di patents nel mondo anglosassone ma un tentativo di fare ordine tra le scartoffie arrivò nella Francia del 1791, quando l’Assemblea Costituente emanò la prima legge per la protezione del brevetto d’invenzione annullando così ogni altra forma di privilegio in tal senso derivante dall’Ancient Régime. Un cambiamento su modello statunitense, che già ci aveva pensato una manciata di anni prima.
L’Italia acquisì, di riflesso, il termine dalla legislazione francese, per cause di forza maggiore: bentornato a casa, brevetto.
© Riproduzione Riservata
Bibliografia
Breve, Brevetto in Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana, Milano, Sonzogno
eDIL – Electronic Dictionary of the Irish Language, s.v. breib; s.v. brì
Brevis, breve in Du Cange, et al., Glossarium mediæ et infimæ latinitatis., Niort: L. Favre, 1883-1887.
Brachys, Brevis in Mohammad Diab, Lexicon of Orthopædic Etymologyis, Harwood Academic Publishers, 1999
Letters Patents in Cassell’s Latin Dictionary, revised by Marchant & Charles, Cassel, London, 1928
Vecchio, Nicola Alessandro, La brevettabilità del DNA umano, Primiceri Editore, Padova, 2016
Merlin, Philippe Antoine, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Volume 2, Garnery Ed., Parigi, 1827
Galasso, Alberto; Comino, Stefano; Graziano, Clara, Market Power and Patent Strategies: Evidence from Renaissance Venice, The Journal of Industrial Economics, in fase di pubblicazione (preview online: http://www.jindec.org/?q=article/market-power-and-patent-strategies-evidence-renaissance-venice)
Image credits: Codice Atlantico, 909v. – Viti brunelleschiane per l’opera di Santa Liberata (Duomo di Firenze) in un progetto di sfondacarene, c. 1487
Per gentile concessione di Alessandro Vezzosi. Fonte: La Toscana di Leonardo
Altro da Nomen Omen: