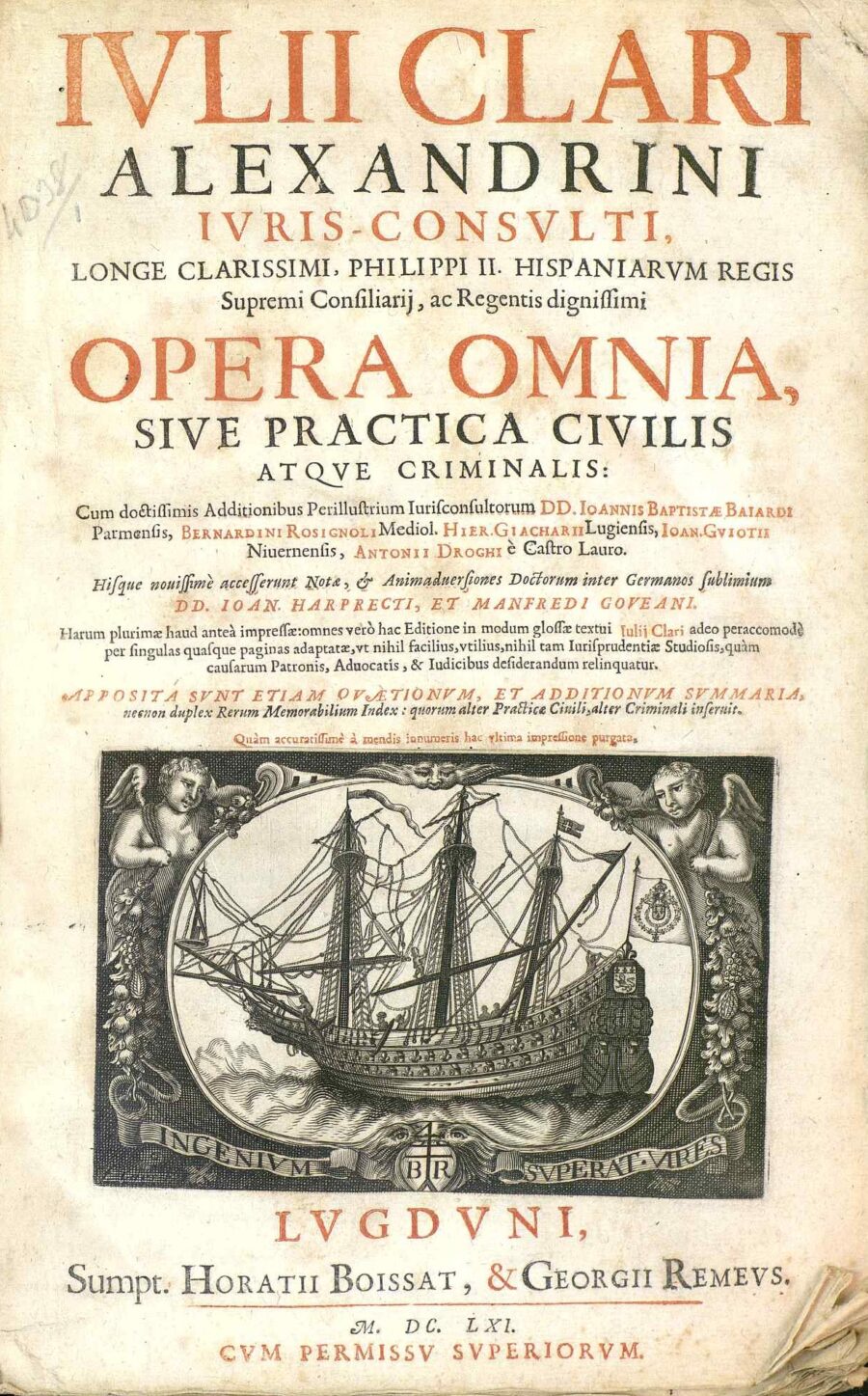Nacque ad Alessandria il 6 Gennaio 1525 da Giovanni Luigi e da Ippolita Gambaruti, entrambi patrizi.
I primi anni di Claro trascorsero tra Alessandria e Milano, in un ambiente sociale ricco di relazioni e coltivato intellettualmente, soprattutto già indirizzato ad assicurarsi un posto di rilievo nella vita dello Stato in virtù del possesso di strumenti tecnici e di attitudini – il sapere giuridico, l’arte di “servire” il principe – assorbiti con naturalezza sin dall’infanzia.
Sappiamo invece ben poco degli studi universitari. Lo stesso Claro, in alcune questioni discusse nel terzo libro delle Sententiae receptae (§ Testamentum, q. 37, n. 2; q. 46, n. 2; q. 63, nn. 1-2; q. 66, n. 5), nominava come suoi maestri, oltre all’Alciato, due noti professori pavesi: Niccolò Belloni e lacopo Alba, e accennava pure a un periodo trascorso presso l’università di Bologna. Nell’epistola dedicatoria della medesima parte sui testamenti, indirizzata nel 1559 al potente consigliere di Filippo II Antoine Perrenot de Granvelle, uno dei più autorevoli tra i suoi protettori ed amici, egli ricordava il tempo trascorso insieme seguendo i corsi di diritto a Pavia.
Stando a questo cenno autobiografico, l’inizio degli studi universitari di Claro va posto non oltre la fine del 1536: ad un’età certo acerba, e da considerarsi tale anche in quel secolo XVI, che vide non di rado carriere molto precoci. Furono comunque studi intensissimi, a giudicare dal dominio d’ogni sorta di testi giuridici che si dispiegò fin dai primi lavori, iniziati mentre stava per concludersi l’iter scolastico, o poco dopo. L’insegnamento dell’Alciato non poté essere senza peso: troppo energico era il suo esempio di accortezza critica nell’utilizzare le fonti, d’indipendenza rispetto agli interpreti anche più famosi, d’inclinazione a tradurre le ragioni della filologia e dell’erudizione in una severa attenzione per l’elaborazione dogmatica dei concetti, perché l’allievo non dovesse restarne influenzato. Soprattutto, l’insegnamento dell’Alciato dovette svolgere un ruolo essenziale nell’indirizzare Claro verso un umanesimo largo ed aperto, scevro da punte polemiche, ch’egli seppe vivere come un abito ormai naturale d’ogni buon giurista.
Sul principio del 1550 Claro conseguì il dottorato a Pavia. Subito dopo fece ritorno ad Alessandria, dedicandosi ad un’intensa attività consulente che lo impegnò per sei anni, senza peraltro impedirgli di porre mano ad un imponente lavoro giuridico, col quale si riprometteva di raggiungere la “gloria” e così realizzare un suo radicato ideale umanistico.
Il più importante di questi lavori è le Sententiae receptae, la cui prima stesura fu compiuta tra gli inizi del 1550 ed il luglio 1555.
Conservata in forma quasi completa presso la Biblioteca Ambrosiana, consente di valutare sia il piano e l’impostazione dell’opera, rispecchiati nelle prime parti mandate alle stampe, sia l’evolversi di una posizione scientifica e intellettuale, destinata a trovare compimento nel famosissimo Liber V. Sotto il titolo, che richiamava intenzionalmente l’esempio dell’opera celebre dell’antico giurista classico Paolo, si raccoglieva un repertorio vastissimo di opinioni giurisprudenziali sulle materie più controverse del diritto civile. Il modello classico, tuttavia, era poco più di un prestigioso blasone, di un ossequio tributato alla giurisprudenza umanistica, utilizzata del resto con molta larghezza. Presente e vivissima era l’intera tradizione enciclopedica e lessicografica medievale, riorganizzata però in funzione di un’ispirazione diversa, che aveva altrove i suoi punti di riferimento e che esprimeva in modo assai chiaro il profondo mutare della giurisprudenza a metà Cinquecento, il suo passare dall’ambiziosa progettualità del periodo umanistico alla più dimessa, ma efficace strumentalità dei secoli dell’ancien régime.
Secondo il piano originario, l’opera avrebbe dovuto dividersi in sette libri, dei quali furono scritti solo i primi quattro, con un’ampiezza però che travalicava le intenzioni iniziali, spezzando frequentemente l’ordine alfabetico degli argomenti, che Claro aveva prescelto seguendo una tipica tradizione dei repertori tardomedievali. Nel 1558 la parte relativa ai feudi, tratta dal libro quarto, fu pubblicata a Milano; nel 1559, con una dedica al Granvelle, al quale si riconosceva il merito di avere appoggiato in vari modi l’autore e di averlo incitato a pubblicare i suoi lavori, apparve a Cremona la parte sui testamenti del libro terzo. Infine, sempre nel 1559, con una dedica a Ferdinando di Cordova, duca di Sessa e governatore di Milano, le parti del libro quarto sulle donazioni, sull’enfiteusi, e di nuovo quella sui feudi. Riunite insieme sotto il titolo di Tractatus quatuor…, con un ordine non sempre immutato e con modifiche di sostanza che esprimevano una maggiore autonomia di giudizio rispetto alle autorità tradizionali, furono ristampate nel 1565, e poi in seguito, da sole o col Liber V, sotto diverse indicazioni nel titolo, numerosissime volte sino alla prima metà del Settecento.
Nel frattempo, Claro aveva percorso molti gradi nelle magistrature. Nel 1556 era entrato a far parte del Senato di Milano. La nomina gli giunse a Mantova, dove si era recato per sfuggire ai pericoli della guerra franco-spagnola: da quella città il 7 febbraio indirizzava una lettera ai presidenti e agli Anziani di Alessandria, ringraziandoli per l’appoggio prestato alla sua candidatura.
In qualità di senatore, nel gennaio 1558 Claro partecipò al giudizio di sindacato sul podestà di Cremona. Nella stessa città, fu poi pretore nel biennio 1560-61, svolgendo non solo compiti giudiziari, ma fronteggiando anche i rovesci di una durissima carestia, i tumulti interni, i contrasti politici con i territori confinanti, e perciò meritandosi la cittadinanza onoraria e addirittura una statua dai Cremonesi riconoscenti.
Claro fu poi nominato presidente del magistrato straordinario delle Entrate, istituito in aprile da Filippo II sdoppiando di nuovo il magistrato dei Redditi.
Seconda solo al Senato per autorità e per prestigio, la magistratura aveva il controllo esclusivo delle rendite ordinarie dello Stato e di quelle patrimoniali del principe, con una larga competenza sulle materie finanziarie, limitata solo parzialmente dalla giurisdizione concorrente del Senato, e partecipava con diritto di voto al Consiglio del governatore.
Claro ricoprì l’ufficio con molta energia. Collocato in un posto altissimo dell’amministrazione milanese e spagnola, interpretò fino in fondo il suo ruolo di grand commis, intrattenendo rapporti con le maggiori autorità dello Stato, affrontando conflitti di competenza col governatore e il Senato, stabilendo un diretto dialogo con Filippo II. Forte di questa rilevante esperienza politica, giudiziaria e amministrativa, egli rivedeva frattanto la sua opera scientifica. Nel 1565 pubblicò – come si è visto – l’edizione ampiamente rimaneggiata delle parti già edite del terzo e del quarto libro delle Sententiae. Alla stessa data, aveva già preparato per le stampe il Liber V.
La pubblicazione però fu impedita dalla nomina a reggente nel Consiglio d’Italia, ottenuta nel settembre 1565. In novembre egli era già presso la corte spagnola, dove rimase per circa dieci anni, se si escludono i viaggi in Italia compiuti per motivi familiari e più spesso di ufficio. Nel suo incarico, ebbe modo di scrivere numerosi pareri su controversie giuridiche di scottante rilievo politico.
Tra il 1572 e il 1575 Claro fu consultato ancora frequentemente su questioni d’interesse giuridico-politico, per esempio da don Giovanni, da Filippo II, dal duca di Savoia. La morte lo colse improvvisamente a Cartagena il 13 Aprile 1575, mentre si recava a Genova per incarico del re di Spagna.
Nel 1568, con una dedica a Filippo II, Claro aveva pubblicato il Liber V Sententiarum: un’opera tra le più famose della giurisprudenza d’ancien régime, destinata a ottenere numerose ristampe e ad accrescersi con svariate addizioni di altri giuristi, la quale fondò per secoli l’altissima autorità di Claro in tutta Europa tra i pratici e gli studiosi di diritto criminale.
Dopo un paragrafo iniziale, che costituiva uno dei primi tentativi di preporre una sorta di Parte generale alla trattazione dei vari istituti penalistici, ne seguivano altri venti, dedicati a vari delitti e disposti in ordine alfabetico. Infine, il paragrafo XXII, molto esteso ed intitolato Finalis Practica criminalis, affrontava prevalentemente la materia processualistica. Va sottolineato come il Liber V esprimesse una delle posizioni culturali più significative della criminalistica europea, impersonando con grande efficacia atteggiamenti scientifici e schemi espositivi propri della penalistica italiana, molto legata ai metodi del tardo commento, che le consentirono di esercitare un lungo predominio in Europa nei secoli dal XVI al XVIII.
Simili posizioni illustrano ampiamente i motivi della enorme fortuna di Claro fra i teorici del diritto sia nella pratica giudiziaria dell’ancien régime. Per secoli nella sua opera si apprezzò non soltanto l’autorità del giurista dottore e consulente, capace di dominare con sicura maestria l’intera tradizione giuridica medievale e al tempo stesso i risultati migliori della giurisprudenza umanistica, ma anche e particolarmente l’esperienza del giurista grande burocrate e grande funzionario, interprete rappresentativo di quel ceto forense che incominciava a profilarsi nelle società europee coordinando la propria forza e la propria capacità d’indirizzo intorno ai tribunali supremi – organismi giudiziari e politici insieme – dei vari Stati; che incominciava a porsi come spina dorsale dei regimi accentrati, come punto di raccordo tra i gruppi sociali e come strumento indispensabile per organizzare il potere e la società. Per l’immediato, nella seconda parte del secolo XVI, le stesse caratteristiche culturali del suo lavoro si proponevano come un’indicazione suggestiva ed efficace. Se da un lato esso continuava a testimoniare un perdurante legame logico-formale coi principi della scienza giuridica dell’antichità e del Medioevo, condizione indispensabile della propria dignità scientifica, dimostrava dall’altro la possibilità di conciliare questa eredità con le nuove regole del sapere umanistico, risolvendo al tempo stesso tutte le aporie teoriche in un’opera quotidiana rivolta alla pratica, di grande rilievo politico e prestigio sociale. Esso, pertanto, poneva il problema di un’alternativa percorribile a quegli intellettuali delusi dal fallimento delle aspirazioni umanistiche, che si proponevano di rinnovare la società rinnovando le scienze e fissando i termini di una nuova civiltà letteraria, e indicava in un tipo nuovo di giurista il raccordo possibile tra intellettuali e potere.