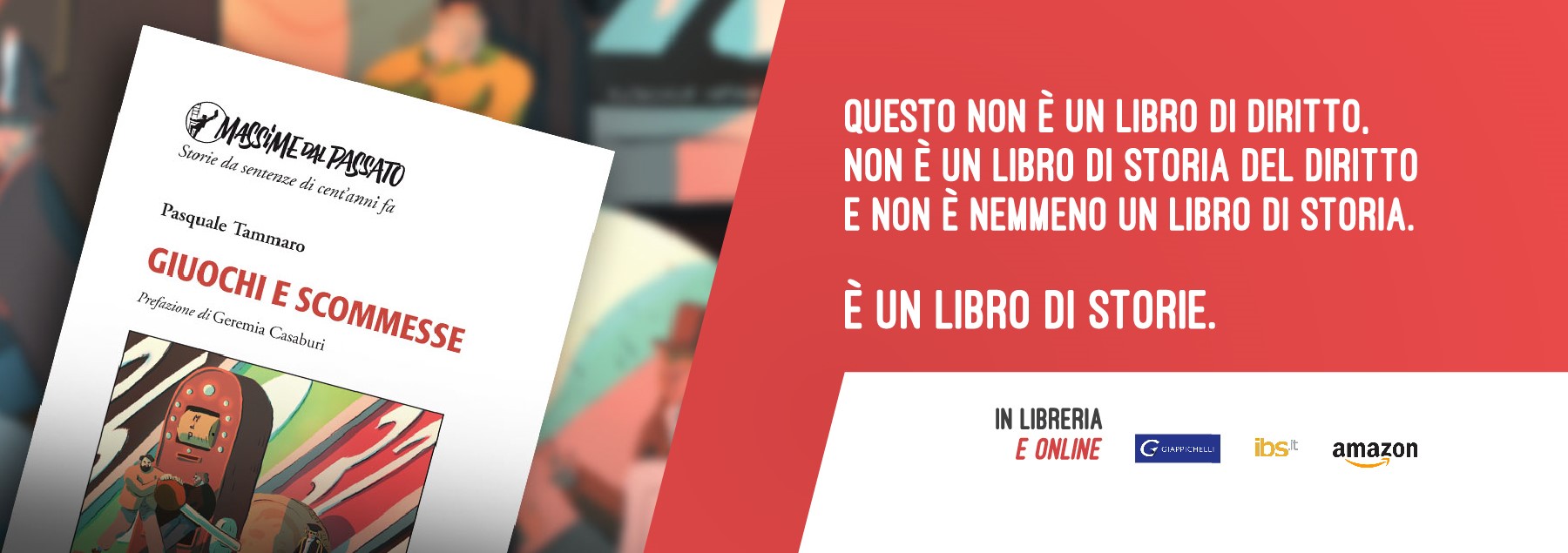56. Solo il Coccodrillo si pente (1919)
Vi avviso. Si tratta di una storia tremenda.
Siamo nel 1918, è settembre. La prima guerra mondiale è quasi finita. Ma i soldati non lo sanno. Non lo sa certamente Bogni Giulio, del 28° reparto d’assalto dislocato in località Malcontento (ah, questi nomi…).
Era al fronte da nemmeno due mesi, sarà stato giovanissimo. Ma a lui della guerra non gliene fregava nulla. Scappò.
Fu preso e tradotto in carcere, in località Case Strette Villarba. Evase.
Giunse a Torino e no, Giulio Bogni non era scappato dalla guerra perché ne aveva paura e voleva vivere. Era scappato perché odiava la disciplina, detestava essere sottotiro, preferiva giocare di anticipo e soprattutto, quando possibile, fottere il prossimo. A Torino fece la bella vita, “vagabondando in ambienti equivoci, mutando spesso nome e vivendo col frutto di truffe, di furti e di rapine”.
La guerra dopo un po’ era pure finita, e la città era invasa da tenenti e ufficiali trovatisi improvvisamente disoccupati. Sono gli ex combattenti che gonfiano i polmoni di una penisola in croce, con una vittoria mutilata in tasca e nulla di che farsene. Con loro, e in particolare con il suo superiore sottotenente Giuseppe Rosi, ragazzo molto ricco, Giulio Bogni se ne va in giro, accompagnandosi a donne nei teatri della capitale di un tempo.
Una sera i due alloggiano assieme in un albergo di Via Po. Bogni è ingolosito dal denaro dell’amico. Si sveglia di notte e lo uccide con quattordici fendenti del suo pugnale di ardito (bell’ardimento…). Gli asporta la misera somma di 77 lire e scappa. Arriva a Milano, dove truffa prostitute portandole con sè al ristorante e lasciando loro il conto da pagare, e infine arriva a Varese dove viene arrestato mentre è colto in flagranza di furto.
Confessa tutto. Anche l’omicidio. E ai carabinieri che gli chiedevano se fosse pentito di quell’orrido reato che tanto aveva fatto parlare anche la stampa, Bogni rispose “solo il coccodrillo si pente“.

Trovate qui sotto (basta cliccare il bottone..) la sentenza del Tribunale Militare di Torino che il 16 aprile 1919 lo condannò a morte. La sentenza non colpisce per la condanna in sè, anche se i giudici si rendono conto trattarsi di una terribile pena, che però non avevano potuto evitare di comminare. Quello che sorprende è il linguaggio di questa sentenza. Una delle più belle se prese dal piglio del racconto e della narrativa. Le parole che tratteggiano l’imputato e tutti gli altri personaggidella storia come se fosse un romanzo noir, la descrizione dei gesti, degli ambienti e dei tempi, tempi cupissimi, nonostante una guerra mezza vinta. C’è anche il cameo del prof. Carrara, uno dei padri della medicina legale.
La sentenza è così vicina alla letteratura vera e propria, che mi sono permesso di dividerla in capitoli, limitandomi ad aggiungerne i titoli.
Buona lettura, coccodrilli.
1. La diserzione
Il 23 settembre 1918, il soldato Bogni Giulio, del 28° reparto d’assalto, si allontanò senza permesso dalla sua compagnia dislocata a Malcontento, mentre essa stava per partire nei camions, per andare in prima linea. Arrestato, fu tradotto il 5 ottobre dai carabinieri alle prigioni del reparto, dislocato allora a Case Strette Villarba, in prima linea; donde però riuscì ad evadere il giorno successivo, asportando i suoi oggetti di corredo e di armamento che non furono più ricuperati.
2. La compagnia di Torino
In seguito il Bogni andò vagabondando per varie città, in ambienti equivoci, ostentando molteplici decorazioni cui non aveva diritto; mutando spesso il nome, e vivendo col frutto di truffe, di furti e di rapine. Valendosi del prestigio derivante dai distintivi al valore da lui abusivamente portati, riuscì in breve a cattivarsi la simpatia e la confidenza di un gruppo di ufficiali che frequentava in ritrovi allegri di Torino, dove anch’egli bazzicava; e segnatamente del tenente Borghi Marino, del sottotenente Rosi Giuseppe e del soldato Matteucci Giuseppe, che allora indossava abusivamente la divisa di capitano degli arditi, costellata anch’essa di molte decorazioni inesistenti.
3. La trappola
La notte del 14 febbraio 1919, all’uscita del teatro «Varietà», il Matteucci chiese se qualcuno poteva alloggiare il Bogni, che quella sera era sprovvisto di camera. Il Rosi che occupava una camera con due letti all’Hotel France in via Po, offri cortesemente ospitalità all’ardito. E poiché il Bogni esitava, il Borghi lo incoraggiò ad accettare.
Separatisi dal Borghi e dal Matteucci e dalle cocóttes, che erano state con loro allo spettacolo, il Rosi e il Bogni si ritiravano nell’albergo, verso le ore 23.
Prima di salire in camera, il sottotenente Rosi avvertì il proprietario dell’albergo, Bertoglio Camillo, che conduceva a dormire con sè quel soldato, e gli raccomandò di farlo svegliare la mattina seguente alle otto.
Un vicino di camera, caporale Gatti Cesare, senti i due a chiacchierare e ridere fin dopo le 24, poi si addormentò e non avverti alcun rumore sospetto durante la notte.
Trovandosi a corto di quattrini e sapendo che il Rosi godeva fama di denaroso, perchè spendeva generosamente per tutti (due giorni prima aveva ricevuto un vaglia di 400 lire dalla famiglia), il Bogni decise di ucciderlo allo scopo di impossessarsi dei suoi denari. Pensò bensì che poteva limitarsi ad asportare i soldi e dileguarsi, ma per timore che l’ufficiale si svegliasse e scoprisse il furto, non desistè dal suo truce proposito. Si alzò verso le sei e mezza in maglia e mutande, e stando tra i due letti, impugnò il suo pugnale da ardito che aveva lasciato sul tavolino da notte.
4. L’omicidio
Si ricordò allora che al fronte si insegna agli arditi di colpire il nemico alla testa e perciò vibrò un primo colpo alla nuca dell’ufficiale che dormiva sul fianco sinistro, ed un secondo colpo alla parete occipitale destra del cranio.
La vittima si svegliò di soprassalto, gemendo sommessamente; ma l’aggressore reiterò i colpi nella testa e sul torace, perforando coll’arma anche il lenzuolo che copriva il Rosi, e ferendolo inoltre alle mani che questi protese in un tentativo disperato di difesa. E non desistette se non quando l’ufficiale, colpito da ben quattordici pugnalate, rotolò, quasi in atto di fuga, dalla sponda opposta del letto, spirando poco dopo, immerso nel proprio sangue.
Compiuto il delitto, il Bogni rovistò tutte le tasche dell’ucciso e ne asportò il portafoglio; contenente alcune carte personali e 77 lire in denaro. Poiché il maglione e le mutande erano sporche di sangue, se li tolse e indossò le mutande e la camicia di seta rossa, i calzoni, il cinturone e il pastrano con colletto e paramani di pelliccia grigia del morto. Distaccò quindi con le forbici il trofeo e il filetto del berretto del Rosi e se lo mise in capo, lasciando sul posto il proprio berretto da ardito col fregio in oro del 28° reparto, nonché le mutande, il maglione, e i calzoni. Quindi, passando vicino al cadavere che era disteso vicino alla porta, uscì chiudendola a chiave che si pose in tasca.
Andò a lavarsi le mani sporche di sangue ad un rubinetto della latrina asciugandole nel fazzoletto e scese.
5. La fuga e il ritrovamento del cadavere
Erano le 7,30. Passando davanti al bureau disse, con voce ed aspetto tranquilli, al facchino dell’albergo, Milano Giovanni, di non svegliare l’ufficiale, perchè la sveglia era stata ordinata per lui e cancellò di proprio pugno l’ora della sveglia che era stata segnata in un’apposita nota.
Si diresse quindi verso la Piazza Gran Madre di Dio, prese una bibita in un caffè; gettò nel Po le carte dell’ucciso, tenendo il portafogli coi denari, e buttò la chiave attraverso la griglia della fognatura esistente nella stessa piazza.
Sali poscia sul tram elettrico per Chivasso, donde proseguì per Milano in un automobile che passava col solo chauffeur, cui dette una mancia di 20 lire. Passarono così alcuni giorni, durante i quali il Rosi fu creduto fuori per servizio. Ma nel pomeriggio del 17, insospettito dalla lunga assenza, il proprietario dell’albergo dette ordine al facchino Milano di aprire in qualunque modo la porta della camera dell’ufficiale. Scassinata la serratura, si rinvenne la stanza in disordine col cadavere.
I sospetti caddero immediatamente sull’ardito che la notte dal 14 al 15 aveva dormito col Rosi. E infatti il berretto col fregio portante il numero 28 ed il maglione furono subito riconosciuti dai tenenti Torchi e Mafera, per quelli che portava l’ardito Bogni.
Dalla perizia medico-legale, eseguita dai professori Carrara e Tovo, previa autopsia ed esame degli indumenti e delle lenzuola sequestrate, risultò che la morte del Rosi risaliva ad almeno 4 giorni dalla sezione cadaverica avvenuta alle ore 15 del 19; che la morte era avvenuta da sei a otto ore dall’ultimo pasto, per effetto delle ferite riscontrate sul cadavere; che l’arma adoperata doveva essere robusta, lunga più di sette centimetri, larga mm. 22, a punta bitagliente e munita, a una certa distanza, di una costa.
In base alla entità delle ferite ed ai fori riscontrati nel lenzuolo e nella maglia, i periti ricostruirono il fatto dell’agressione così: l’uccisore, portatosi fra i due letti, colpì l’ufficiale coricato sul lato sinistro, prima alla nuca, alla mandibola, al dorso ed alla spalla destra. Poi la vittima fece dei movimenti di difesa, riportando, nel voltarsi, una profonda ferita alla regione temporale sinistra. Vistosi sopraffatto, fece pochi movimenti di fuga, rotolando agonizzante dalla parte opposta a quella dell’agressore, dove spirò subito dopo.
6. L’arresto
Intanto il Bogni stava a Milano, girando per diversi alberghi e nascondendosi sotto falso nome. Un giorno invitò a pranzo, al ristorante Biffi, una cocotte, certa Merisio Maria, ma ad un certo punto, col pretesto che era entrato nella sala il suo capitano, si allontanò, lasciando il conto da pagare, conto che dovette saldare la ragazza, ed il pastrano del Rosi appeso all’attaccapanni, che fu poi sequestrato.
Si recò quindi a Varese, dove fu arrestato il 20 febbraio 1919, dal maresciallo dei Carabinieri Tabani Pietro, mentre veniva inseguito dalla folla a causa di un furto tentato in un negozio, nonostante avesse cercato di sottrarsi all’arresto con la rivoltella in pugno.
Interrogato dal maresciallo sul furto commesso, non solo ammise questo reato, ma, senza esserne richiesto, confessò spavaldamente di essere autore dell’assassinio del sottotenente Rosi, di cui i giornali avevano tanto parlato. Soggiunse di aver ucciso l’ufficiale a scopo di furto, nel modo già descritto, ed alla domanda se fosse pentito, rispose cinicamente:
«Solo il coccodrillo si pente».
Gli fu quindi sequestrato il pugnale da ardito, col quale diceva di aver compiuto l’assassinio.
Tradotto a Torino, fu riconosciuto dal facchino dell’albergo per l’ardito che la mattina del 15, verso le 7,30, aveva cancellato l’ora della sveglia e raccomandato di non svegliare l’ufficiale perché l’ora della sveglia era stata segnata per lui. Anche il pastrano con pelliccia, lasciato nel ristorante Biffi di Milano, fu riconosciuto di pertinenza dell’assassinato, e così pure i calzoni che indossava l’arrestato, perché portavano una rammendatura al ginocchio, eseguita, nel pomeriggio del 14, dalla cameriera dell’albergo, Ferrua Maria, dietro incarico dell’ufficiale. Il Bogni confessò inoltre di aver ucciso in territorio di Treviso, un mediatore, per derubarlo, ed il delitto risultò effettivamente consumato nelle circostanze da lui indicate.
7. Il processo
Il Bogni fu rinviato a giudizio davanti a questo tribunale non solo per la insubordinazione e il porto abusivo di distintivi, ma anche per la diserzione e l’alienazione di effetti militari commessi in zona di operazione. Si dichiarò invece non luogo a procedere per insufficienza di indizi, nei riguardi del Matteucci, che era stato accusato dal Bogni di correità morale nell’omicidio del Rosi, durante l’istruttoria scritta.
Alcuni giorni prima del dibattimento, la difesa fece istanza per l’ammissione della perizia psichiatrica dell’accusato, ed essendo stata respinta dal presidente, fu rinnovata in via preliminare alla udienza, rimettendosene però la decisione al merito. In appoggio alla deduzione peritale, la difesa asserì che il Bogni era stato condannato dal tribunale di Busto Arsizio, col beneficio della semi-infermità mentale. Ma prima della chiusura del di battimento pervenne risposta telegrafica attestante che non solo la semi-infermità non era stata concessa, ma non era stata neppure richiesta.
Cronologicamente, il primo delitto commesso dal Bogni, fra quelli oggi addebitatigli, è la diserzione in presenza del nemico. È risaputo che, per l’essenza di questo reato, è irrilevante il movente, che l’accusato designa, senza dimostrarlo, in una provocazione ad opera di un superiore che gli avrebbe dato due schiaffi. Per la perfezione giuridica di questa figura delittuosa, basta stabilire l’arbitraria assenza dal Corpo e la volontarietà del fatto. E poiché lo stesso accusato non contesta nè l’estremo subbiettivo, nè quello obbiettivo, i quali, del resto, emergono evidenti anche dagli atti processuali, è inevitabile l’affermazione della sua responsabilità penale.
Responsabilità grave, in quanto si tratta di diserzione in presenza del nemico, essendosi egli allontanato dal suo reparto, la prima volta mentre la compagnia saliva sui camions per recarsi in prima linea; e la seconda quando questa si trovava effettivamente sulla linea del fuoco. Oltre a ciò, la diserzione assume un carattere di speciale gravità, perchè qualificata dal tempo, essendosi protratta per oltre un mese. E poiché trattasi di un recidivo multiplo, che ha riportato due condanne per delitti contro la proprietà a pena superiore a sei mesi, indegno pertanto del beneficio dell’amnistia, a sensi dell’art. 18 decreto luogotenenziale 21 febbraio 1919, n. 157, devono essere mantenute a suo carico anche le minori imputazioni di alienazione di effetti militari e di porto abusivo di distintivi. Non solo non furono ricuperati gli oggetti di armamento, ma neppure la maggior parte di quelli di corredo personale, asportati dal giudicabile all’atto della diserzione.
Circa le decorazioni, lo stesso accusato ammette di averle sempre portate arbitrariamente. Nè gli potevano legittimamente competere, avendo prestato due soli mesi al fronte, e non avendo mai partecipato a combattimenti. In ordine alla insubordinazione, che costituisce l’addebita più grave, la prima indagine da farsi è la seguente: se il Bogni sia l’autore materiale dell’omicidio del Rosi.
Anche supposto che in questa causa fosse mancato l’ausilio, innegabilmente prezioso, della piena confessione dell’accasato, gli indizi attinti da altre fonti probatorie sarebbero sempre stati così numerosi, così gravi e significativi, da ingenerare nella coscienza del Collegio la convinzione assoluta ed indeclinabile che il Bogni, e non altri, è l’autore di così efferrato delitto.
Altrettanto deve dirsi in ordine al dolo specifico del delitto di omicidio, all’animus necandi. Il giudicabile non ha contestato il fine di uccidere: ma ogni sua negativa in proposito sarebbe stata vana ed assurda, giacché esso scaturisce in modo inoppugnabile dalla natura dell’arma usata; dalla violenza dei colpi; dalle sedi vitali prese di mira e dalla molteplicità delle ferite, le quali dimostrano che
l’assassino non si astenne dal colpire, se non quando ebbe la certezza di trovarsi di fronte ad un cadavere.
Ora l’omicidio è giustamente considerato dal legislatore come una via di fatto, anzi come la più grave delle vie di fatto enumerate nell’art. 124 cod. proc. pen.; e poiché fu consumato da un inferiore in danno di un suo superiore sottotenente, sorge la figura criminosa specifica di insubordinazione con vie di tatto verso superiore ufficiale.
Nè si può ragionevolmente ritenere, come la difesa ha sostenuto, che esuli la configurabilità della insubordinazione, per fatto che il Bogni aveva intenzione di rubare e non di offendere, e che quindi ha inteso uccidere il Rosi, come uomo e non come superiore. È ormai assiomatico, in dottrina e in giurisprudenza, che per la giuridica perfezione della insubordinazione non occorra il dolo specifico, e l’intenzione diretta ed esclusiva di offendere il superiore come tale, ma basti il semplice dolo generico, la scienza e coscienza del grado superiore della persona lesa; giacché nell’offesa al superiore, qualunque sia il movento che la determina, è sempre ed inseparabilmente insita l’offesa alla subordinazione gerarchica militare.
Qui non v’è solo la lesione del diritto fondamentale dell’uomo alla propria integrità personale, ma sia aggiunge la lesione ulteriore del diritto sociale alla integrità dell’Esercito e alla indissolubilità della disciplina. L’uccisione di un ufficiale, perpetrata da un inferiore, costituisce evidentemente uno dei più pericolosi attacchi alla compagine della milizia; e pertanto il titolo originario di omicidio, aggravato dalla qualifica di superiore del soggetto passivo, si tramuta in quello di insubordinazione, di cui rappresenta anzi la forma più violenta e più irriverente.
8. L’estremo tentativo difensivo: infermità mentale
Senonchè la difesa, impressionata dall’evidenza della prova, e quasi sgomenta dell’atrocità del delitto, ha trasportato la discussione nel campo della imputabilità morale. Essa ha insistito per l’ammissione della perizia psichiatrica, tentando di dimostrare che il Bogni è un delinquente nato, che, come tale, è un anormale e quindi pazzo.
Evidentemente la difesa confonde la criminalità con la pazzia.
Il Collegio non dissente dalla difesa nel ritenere il Bogni un criminale atavico, giacché si riscontrano in lui tutte le caratteristiche psichiche del delinquente costituzionale, quale la indifferenza per gli strazi e la morte altrui, la sproporzione tra il movente e la gravità del reato, l’imprevidenza, il vagabondaggio, la ripugnanza al lavoro, la vanità del delitto, la recidiva frequente e precoce, il mendacio, ecc.
Ma lo stesso Carrara, invocato dalla difesa, tiene accuratamente distinta la figura del delinquente nato, nel quale il delitto, è esclusivamente dovuto al fattore antropologico, all’anomalia di struttura per ragioni d’atavismo, da quella del delinquente pazzo nel quale all’alterazione tipica della criminalità, che è la lesione etica, si associano anche i disturbi intellettuali.
Insegna la scuola positiva che tra criminalità e pazzia non vi è differenza di natura, ma di grado. Anomalo è tanto il pazzo, quanto il criminale; ma bisogna distinguere, caso per caso, dove alla criminalità, si sovrapponga la pazzia, e in quali casi quindi si imponga la necessità d’una perizia psichiatrica che accerti e identifichi clinicamente la forma di infermità mentale di cui il delinquente è affetto.
In caso diverso, poiché è un postulato della scienza giuridica positiva che soltanto l’individuo anormale può delinquere, dovrebbe intervenire una perizia in tutti i processi. Ciò sarebbe assurdo, in quanto che, nella grande maggioranza dei casi, il fenomeno criminoso e dovuto ad una anomalia criminale punibile.
L’esame psichiatrico resta quindi naturalmente e giuridicamente limitato ai casi, fortunatamente rari, di anomalie pazzesche o semi-pazzesche non punibili, o punibili parzialmente.
Ora quella del Bogni non è la mentalità squilibrata e ottenebrata dall’alienato, ma la mentalità lucida e ferma del selvaggio, del primitivo, del vero tipo criminale atavico, forse non meno pericoloso del demente ma perfettamente imputabile. Nulla è risultato, né all’istruttoria scritta nè all’orale, che abbia potuto fornire al tribunale il più lontano e vago indizio nel giudicabile di uno sconvolgimento, di una perturbazione morbosa tale da sopprimere o affievolire in lui le facoltà intellettuali e volitive. Nessuna tara nel gentilizio, chè anzi egli appartiene a famiglia equilibrata ed onesta, non malattie gravi durante lo sviluppo fisico-psichico; non manifestazioni di disintegrazione della coscienza nel corso della sua vita civile e militare; persino quel tenue indizio di disorganizzazione psichica, che la difesa sperava di poter desumere da una precedente condanna inflitta con la diminuente della semi-infermità mentale, è venuto, all’ultimo momento a mancare.
9. La pena
Affermata così la responsabilità penale dell’accusato in ordine a tutti i reati scrittigli, non resta che applicare la pena.
Per i due reati minori di porto abusivo di distintivi e di alienazione di effetti militari, si ritiene adeguata la pena di sei mesi di carcere militare per ciascuno, la quale deve ritenersi assorbita dalla pena di morte, previa degradazione comminata dal legislatore, sia per la diserzione in presenza del nemico, sia per la insubordinazione con omicidio contro superiore ufficiale.
Prima di infliggere questa terribile pena, che pensatori e giuristi han conteso al diritto punitivo umano, ma che il legislatore militare ha conservato in disposizioni positive che il magistrato è tenuto ad applicare, il Collegio ha adempiuto al suo ultimo e supremo dovere di scendere e scrutare nell’intima sensibilità della propria coscienza di uomini, di militari e di giudici, onde rinvenirvi un motivo, una ragione qualsiasi, subbiettiva, che potesse giustificare la concessione delle circostanze attenuanti.
Ma nessuna ragione, nessun motivo di clemenza il tribunale ha trovato, nello scrupoloso esame della materialità del fatto e della personalità del delinquente.
Non un sussulto passionale, non un palpito pietoso nobilita il motivo determinante del delitto; unico incentivo alla strage fu l’ingordigia del denaro, e per la misera somma di 77 lire, una vita umana fu inesorabilmente troncata.
L’arma assassina si è abbattuta sopra un giovane buono, generoso, ancora ignaro della vita; si è abbattuta freddamente sul superiore, sul benefattore, sull’ospite, che sono persone sacre per chi nutre la religione dei doveri militari e civili; e si è abbattuta vigliaccamente, tradimento, sopra un fanciullo che dormiva, che sognava forse la sua mamma lontana, e ha fatto strazio con ben quattordici ferite.
Nella sua cieca bramosia di denaro e di sangue, la bestia umana non ha avuto un momento di esitazione e di pietà, quando la sua vittima ha tentato gemendo e forse implorando, di opporsi e quella ingiusta e feroce agressione; non ha sentito un fremito d’orrore nel frugare le tasche del morto; nello spogliarsi degli abiti lordi di sangue innocente; nell’allestire e indossare quelli dell’ucciso, sempre in presenza di un cadavere. E costui è uscito tranquillo dall’albergo; ha avuto la forza di animo di abbandonarsi a bagordi e a nuovi reati; ha confessato cinicamente il proprio delitto e si è accusato spavalda mente di un’altro omicidio; non ha avuto un fremito di rimorso e neanche di pentimento al ricordo delle sue vittime: neppure un’ombra di commozione quando le arringhe han ricordato in udienza il dolore di sua madre; e si è mantenuto insensibile persino quando ha sentito pro nunziare la pena di morte. Nessuna attenuante dunque può essere accordata, a questo essere mostruoso, che fu cattivo cittadino e pessimo soldato, e che si è dimostrato assolutamente incapace di redenzione morale.
Per tutto questo il Collegio, con sicura e tranquilla coscienza, ritiene suo imprescindibile dovere di
eliminare per sempre dall’Esercito e dal consorzio umano questo criminale incorreggibile, che è indegno di farne parte, onde tutelare le supreme ragioni della reintegrazione dell’ordine giuridico e insieme della difesa sociale, specialmente in un tempo e in un luogo in cui l’irrompere della delinquenza minaccia di prendere proporzione allarmante.
Sono conseguenze legali della condanna la degradazione, i danni, le spese, la pubblicazione della sentenza, la confisca e la restituzione delle cose sequestrate.
Per questi motivi, ecc.
(Il foro italiano, 44, 191, II, 249)
© Riproduzione Riservata